«Non adesso, non ancora». Passiamo gran parte della vita a evitare di riflettere sulla morte. E, quando ci ammaliamo o siamo in pericolo, il primo pensiero è sempre: «Non adesso, non ancora. Ho ancora tanti progetti da realizzare, tanti posti da vedere, tante cose da fare». Eppure, paradossalmente, pensare alla morte è un modo di dare senso alla vita. All’estero se ne parla sempre più, al punto che il libro Being Mortal (Essere mortali) del medico Atul Gawande, è stato per mesi in testa alle classifiche negli Usa. In Italia, invece, la morte è spesso ancora un tabù. Ma tacere una cosa non la fa scomparire. Perciò abbiamo chiesto a 4 esperti se sia possibile, e come, prepararsi a morire. Ecco cosa hanno risposto.
«Impariamo dai piccoli malati», Albert Espinosa, scrittore
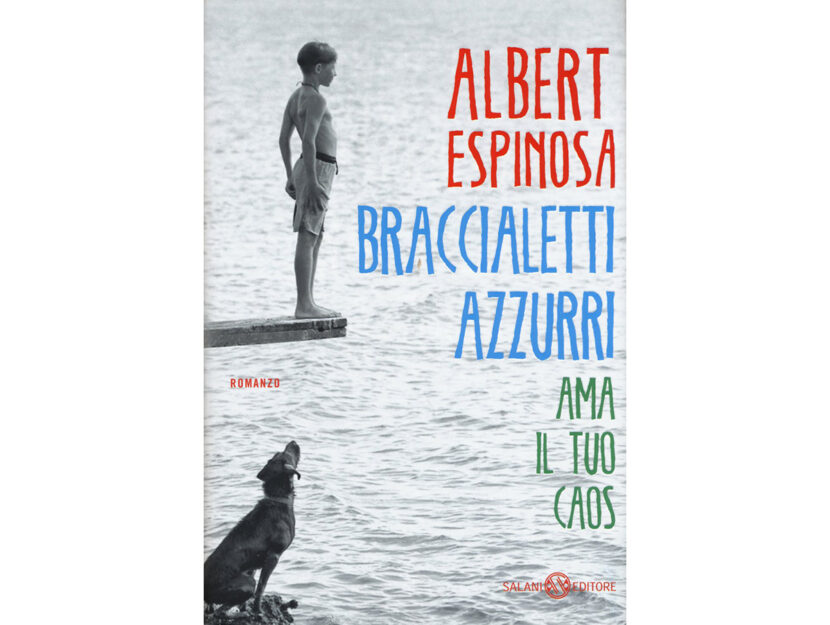
“Braccialetti azzurri” di Albert Espinosa (Salani)
«Imparare a morire non solo si può: si deve. Perché non è un argomento che riguarda unicamente gli anziani. Io l’ho provato sulla mia pelle da ragazzino quando, per un tumore alle ossa, mi hanno tolto una gamba, un polmone e parte del fegato. Ho vissuto in ospedale dai 14 ai 24 anni. Durante quel periodo, che ha ispirato i miei libri, mi sono reso conto che per me e per gli altri giovani malati la morte era una compagna quotidiana, di cui parlare tranquillamente. Invece vedo che gli adulti non la menzionano mai con i bambini, al punto da inventare bugie quando muore un parente. Così facendo, però, li riempiono di paure, perché nulla terrorizza più di ciò che non si conosce. La ragione di questo comportamento? La spinta da parte della nostra società a comportarci, e quindi a consumare, come se fossimo eterni. Una sorta di censura culturale che esclude la morte dai discorsi socialmente accettabili. Il risultato è che viviamo tutti in una “bolla”, dimenticando ciò che, alla fine, può dare un senso all’esistenza. Invece dovremmo introdurre questo concetto nei nostri discorsi, anche e soprattutto con i bambini. Solo pensando che non è eterna, la vita diventa un dono da godere finché si può. La cosa triste non è smettere di vivere, ma non farlo intensamente. Troppe volte, come diceva lo scrittore Charles Dickens, “si muore a 27 anni, ma si viene seppelliti a 72”».
«Non pensiamo alla morte come a un nemico», Gian Domenico Borasio, docente di Cure palliative all’Università di Losanna
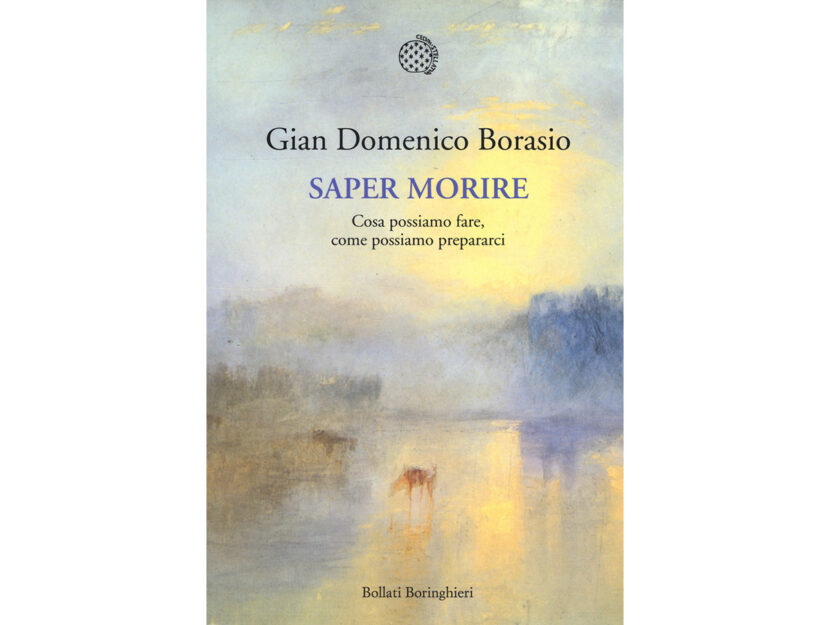
“Saper morire” di Gian Domenico Borasio (Bollati Boringhieri)
«Una volta un mio paziente mi ha detto: “Pensiamo che siano i vivi a chiudere gli occhi ai morti. In realtà sono i morenti che aprono gli occhi dei vivi”. Questa frase esprime una profonda verità: la morte ti obbliga a fare i conti con la vita. Eppure oggi impera l’incapacità di rassegnarsi alla fine. La colpa spetta in gran parte a noi medici: dagli anni ’50 in poi la ricerca ha fatto enormi progressi, riducendo sempre più la sofferenza fisica negli ultimi istanti. Ma allo stesso tempo ci ha illuso di essere onnipotenti e di riuscire un giorno a diventare immortali. Di qui la visione della morte come un nemico da sconfiggere, magari grazie a qualche nuovo farmaco risolutivo. Ma concentrarsi solo sul futuro, su ciò che potremo fare vivendo più a lungo, ci fa smarrire il senso del presente. Una ricerca internazionale sulla gerarchia di valori di 20.000 malati terminali ha evidenziato che, per quasi tutti, il maggior rimpianto derivava dal fatto di non essere stati più altruisti. Perfino la salute, che avremmo ritenuto il valore più importante per chi vede la morte in faccia, per loro contava molto meno della spinta verso gli altri. Dunque accettare la morte si può, a patto di prepararsi per tutta la vita, concentrandosi su quello che la rende più piena. Nella mia esperienza di medico, ho visto che chi ha cercato solo il denaro o il prestigio spesso muore inferocito con Dio o la sorte, mentre chi ha perseguito la generosità se ne va in pace con se stesso. In fondo, l’altruismo, come spiega il Dalai Lama, è una forma di egoismo intelligente, che ci aiuta a dare un senso a ciò che lasciamo dietro di noi».
«Smettiamo di voler controllare tutto», Wilhem Schmid, filosofo

“Serenità” di Wilhelm Schmid (Fazi)
«Non sappiamo “morire bene” perché viviamo male. La società ci spinge al controllo, spronandoci a fare piani di previdenza, pianificare il futuro, monitorare tanto gli impegni quanto i parametri del nostro corpo, conquistare sempre nuovi obiettivi. E la morte ci è insopportabile perché intralcia i nostri programmi. Per questo, anche se la vita media si allunga, non ne abbiamo mai abbastanza. La soluzione sta nel mutare approccio e, anziché cercare di dirigere gli eventi, accettarli. Accontentarci, anziché chiedere di più. Invece di imporre il nostro volere, lasciare andare le cose come vanno. In tedesco serenità si dice “Gelassenheit”, un termine che contiene il verbo “lassen”, lasciare, affidarsi. Ciò non significa diventare rinunciatari, ma, dato che il tempo è limitato, fare di un ostacolo lo spunto per interrogarci sulla direzione che seguiamo: finché corriamo affannosamente, ostinandoci a raggiungere un traguardo dopo l’altro, dimentichiamo il senso del cammino. E se vale la pena di insistere su quella strada o sia meglio trovarne una diversa, che magari ci renda più felici».
«Facciamo dei corsi all’Università», Ines Testoni, direttrice del master in Death Studies all’Università di Padova
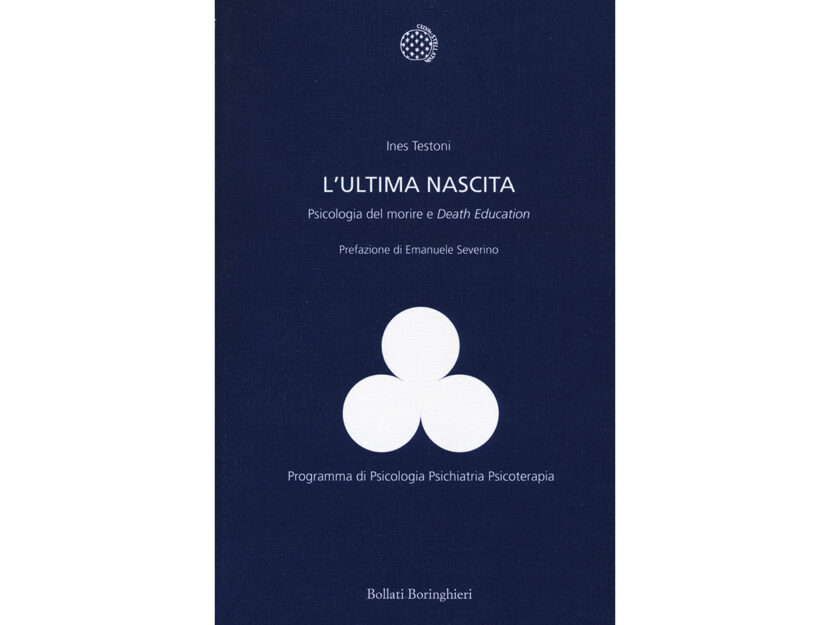
“L’ultima nascita” di Ines Testoni (Bollati Boringhieri)
«Imparare ad accettare la morte è difficile quando l’intera società “congiura” per farcela dimenticare. Esiste una teoria psicologica chiamata Terror management theory, secondo cui tutti i prodotti culturali sono forme di difesa nei confronti della paura di morire: dato che questo terrore rischia di paralizzare la specie umana, da sempre la collettività elabora dei riti che ci anestetizzano e ne rimuovono il pensiero. A questo servono, per esempio, film, libri e fumetti che hanno per protagonisti zombie, demoni e alieni. La spettacolarizzazione è un processo catartico: vedere la morte capitare ad altri crea una sorta di distacco emotivo, ci abitua a pensare che la fine esista, sì, ma non riguardi noi. Un processo ancora più diffuso e necessario oggi che si sono indebolite le grandi religioni e fatichiamo a trovare una spiegazione del perché si debba morire. Ma tacere le nostre angosce ci impedisce di agire per superarle. Come uscire da questa “spirale del silenzio”? Discutendo insieme proprio di ciò che più ci spaventa. All’estero si pubblicano libri, si tengono incontri. Da noi tutto questo manca. Servirebbero articoli sui giornali, dibattiti tv, perfino corsi all’università: il nostro Master a Padova è rivolto a infermieri e assistenti sociali, ci vorrebbero corsi aperti a tutti. Siamo un Paese che invecchia, ed è timoroso e sfuggente rispetto alla morte. Però solo se affrontiamo questo vuoto culturale possiamo riempirlo di senso. Per non arrivare impreparati davanti all’evento più prevedibile della vita».
