Non è sempre facile dividere l’ufficio o il tavolo di un cda, se a separarti dall’altro ci sono vent’anni di età. Pensandoci, a chi non viene in mente qualche scontro epico tra padri e figli, giovani e “vecchi” manager, neoassunti alle prese con impiegati monolitici? Oggi, poi, a dividere ufficio e scrivania sono ben quattro generazioni: si va dagli anziani Baby boomers (il 6%) alla Generazione X (35%), dai Millennials (altro 35%) fino agli ultimi arrivati della Gen Z (25%). Se ci aggiungiamo il fatto che il 45% delle medie imprese italiane è alle prese con il passaggio generazionale, è facile immaginare quanto il gestire sensibilità e competenze tanto diverse sia destinato a diventare un tema cruciale del mondo del lavoro.
«Chi è nato nello stesso periodo condivide esperienze simili, ha un modo comune di vedere e interpretare la realtà. E le differenze con gli altri si sentono, anche in ufficio» spiega Beatrice Manzoni, professoressa associata alla SDA Bocconi School of Management e autrice con Federico Magni di una ricerca su motivazione e aspettative delle diverse generazioni in azienda. Lo studio rivela che in realtà aspirazioni e desideri sono spesso simili. «Con la differenza che i giovani si aspettano tanto e sono fiduciosi di poter ricevere di più dalle aziende» aggiunge l’esperta. «Quello che sappiamo è che ognuno ha bisogno delle competenze dell’altro, ci si completa a vicenda. Facciamo un esempio concreto: con l’età peggiorano la memoria di breve termine, la fluidità di ragionamento e l’originalità, ma migliorano autoefficacia, resilienza, abilità nello scegliere collaboratori capaci, cose che mancano a chi è più giovane».
Per comporre questo complicato puzzle intergenerazionale non esiste una formula magica: «Serve la disponibilità a capire chi ci è di fronte e a riflettere sul fatto che ciascuno ha qualcosa da insegnare. Ma prima di tutto bisogna riconoscere e abbattere i pregiudizi. Diamo per scontato che il nostro modo di vedere la realtà sia l’unico possibile o il più efficace, e questo ci porta a volte a giudicare l’altro come un nemico».
C’è però chi è già riuscito ad allargare gli orizzonti e a fare delle differenze di età un tesoro per se stesso e per il proprio business. Come raccontano i protagonisti di queste tre storie.
«Qui uno solo è al comando»
Massimiliano e Vittorio Massia
Se c’è una famiglia che per tradizione sa mettere insieme “ieri” e “oggi” è quella di Massimiliano Massia: i Massia erano già tessitori da due secoli quando nel 1843 Vittorio fondò a Torino l’impresa artigiana di passamaneria destinata a diventare la più antica d’Europa. Da allora, alla guida di questo gioiello che ha servito regnanti e papi si sono succedute sei generazioni, fino a Massimiliano, appunto. «Chiunque è arrivato ha portato qualcosa di suo» racconta. «Nel dopoguerra mio nonno puntò sulla vendita al dettaglio nell’antica bottega di Torino, mio padre ha riaperto la strada al restauro di tessuti antichi, io mi sono dedicato a nuove sperimentazioni e ai nuovi mercati. Il nostro fiore all’occhiello oggi restano i restauri, ma spaziamo dall’allestimento di palazzi storici agli interni di yacht, fino alle collaborazioni con gli stilisti».
Per Massimiliano passare dai broccati per tende agli alamari per i cappotti di Prada è la quotidianità, ma per farlo ha dovuto unire i saperi di due generazioni. Ha iniziato nel 2000, quando è entrato nella squadra a poco più di vent’anni. «Qui ho respirato l’amore per la bellezza, assorbito i segreti dell’artigianato, imparato a gestire i rapporti con i clienti. Da subito i miei mi hanno affidato quello che loro non potevano fare: ricerca e innovazione».
«Se a prendere le decisioni ci sono due persone non può funzionare. Chi “molla” deve saper fare un passo indietro, a testa alta ma con grande umiltà»
Scontri su vedute diverse? «No» assicura suo padre Vittorio, oggi responsabile del museo di famiglia e consulente sulla parte fiscale. «Si parla, ci si confronta, e poi da quando Massimiliano è al comando a decidere è lui. È una sorta di tradizione di famiglia, chi arriva prende il timone, e chi c’era si fa da parte. Non è semplice, ma anche tra me e mio padre è stato così, diversamente non potrebbe funzionare. E se succede che su una commessa “sento puzza di bruciato”, non insisto, guidare un’impresa significa anche prendersi responsabilità». Stare al fianco di suo figlio, spiega Vittorio, gli ha fatto aprire gli occhi su molte cose: «Ho scoperto la potenza della tecnologia e della comunicazione. E ho visto che mi mancava quel pizzico di incoscienza. Noi sabaudi non siamo abituati a rischiare, e con l’età si peggiora. Ecco perché serviva lui».
«Con un nuovo marchio l’azienda di famiglia è rinata»
Alice, Gian Luca e Massimo Vitelli
Quando si sono presentati dal padre con il progetto de La Scarpetta di Venere, Massimo Vitelli non l’ha presa bene. Lui che per 30 anni aveva guidato nelle Marche una fabbrica di scarpe con decine di operai e che produceva per conto terzi, non riusciva a sposare quella stranezza di fare serie uniche, sempre diverse, realizzate con rimanenze di pellami di pregio.
«Come imprenditore era abituato a programmare tutto partendo dalle commesse, io invece volevo fare esattamente il contrario, scarpe originali e sostenibili, senza campionari, che non lasciano invenduti e parlano di chi le fa. “Parti dal punto sbagliato!”, mi ripeteva» ricorda Alice. «Avevo da poco finito la mia tesi di laurea in Economia: Analisi dei costi di prodotto calzaturiero. Mio fratello Gian Luca mi ha detto: “Partiamo”.
Era il 2009 e le cose in azienda non andavano bene: le grandi ditte avevano cominciato a esternalizzare, i clienti non pagavano, mio padre e suo fratello, che erano soci, si erano divisi. Ma lui è un testardo, non mollava. Così io e Gian Luca abbiamo messo sul tavolo la nostra idea: noi due avremmo avuto il nostro marchio e avremmo affidato a papà la produzione».
«L’idea vincente è stata separare le due attività. Solo così papà ha capito che la nostra idea funzionava e con il tempo è diventato il nostro mentor»
Ha funzionato, e quando Massimo ha chiuso la sua impresa si è iniziato a lavorare tutti sotto un solo brand: Gian Luca si occupa della produzione, Alice della parte creativa e commerciale e il papà degli aspetti tecnici. Insostituibile, spiegano: «Le scarpe ce le ha nel Dna. Vede cose che nessuno nota, calcola a mente la superficie di resa di un pellame». Non è stato semplice per lui digerire quella scelta. «Ma mentre loro andavano avanti, io capivo che il mio tempo era fatto» dice. Pian piano ha iniziato a guardare le cose con altri occhi, fino ad affiancarli: «Lui è quello da cui andare se c’è da chiedere un parere sulle lavorazioni o sul pellame. Manca il materiale? Subito ci dice: “Andate da quel tal fornitore, lui vi può aiutare”. Noi intanto portiamo avanti il nostro progetto. Non lo ammetterà mai, ma papà ne è orgoglioso».
«Tutti hanno qualcosa da insegnare»
Patrizia e Stefano, colleghi di Ibm
«Stefano l’ho “trovato” all’inizio del 2020. Il primo giorno l’ho messo alla prova davanti a un caffè. E ho intuito subito che poteva arricchirmi». Patrizia Guaitani è Technology technical community leader in Ibm Italia, guida un team di 200 persone. Da poco più di un anno si è aggiunto alla squadra Stefano Di Cataldo, 23 anni appena, qualifica di Client technical specialist. Di paura ne aveva tanta all’inizio. Paura di non essere all’altezza, di non trovare qualcuno che gli facesse da guida.
Ma le cose sono andate diversamente, e il merito è anche di Patrizia. Lei la spiega così: «Quando entrai nell’ufficio del mio primo capo, a vent’anni, lui mi stupì dicendomi: “Vediamo da oggi cosa posso imparare da lei e lei da me”. A me piace fare lo stesso, crescere “prendendo” da chi ha uno sguardo diverso dal mio. Se c’è da dare un parere su qualcosa, Stefano ha la freschezza e la capacità di dire ciò che pensa, ha una mente aperta ed è molto costruttivo. Questo mi aiuta a non fossilizzarmi su vecchi schemi».
«Il segreto per lavorare in un team multi generazionale? Saper ascoltare e imparare da chi ha uno sguardo diverso dal mio, per non rimanere intrappolata nei soliti schemi»
Per Stefano è stata una sorpresa e una lezione al tempo stesso: «All’inizio ero impaziente. Avevo quella fretta tipica della mia età, che mi portava a chiedermi cosa viene dopo, come mostrare che c’ero anche io. Invece qui ogni giorno si semina e l’ho realizzato quando una mattina mi hanno dato il mio primo incarico. Grazie a quello che avevo imparato ho portato a casa il risultato».
Certo non sempre è facile, chiarisce Patrizia: «Della generazione di mia figlia fatico a condividere questa voglia di dare per scontato che si sa tutto, di correre, senza godersi il viaggio. Non è sempre possibile mettersi nei loro panni. Però possiamo imparare ad ascoltarsi e ascoltare. Infatti oggi ne ho portati 16 a prendere un caffè».
Un mediatore per far parlare nipoti e nonni nelle imprese
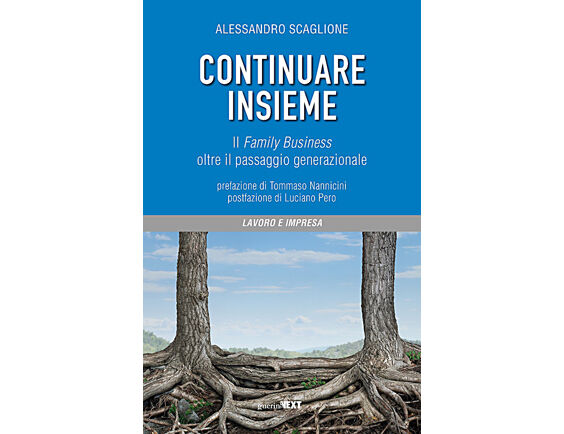
di Myriam Defilippi
In Italia le imprese familiari sono tante, ma neanche 2 su 10 arrivano alla terza generazione. A spiegarci perché il passaggio generazionale sia così delicato è Alessandro Scaglione, ingegnere esperto di aziende familiari e autore di Continuare insieme (Guerini Next). «Quasi sempre a capo dell’impresa c’è un uomo che ne percepisce il possesso in modo viscerale, come se nel crearla avesse partorito un figlio, e designa il successore come se la loro fosse una dinastia. Di norma, lo scettro va al primogenito o comunque al maschio. Le figlie finiscono in ruoli amministrativi o nell’eventuale fondazione di famiglia, cioè in un recinto – per quanto dorato – in ambito sociale. Per favorire il passaggio generazionale il primo passo è invece un percorso di consapevolezza nel senior che tiene le redini: deve valutare chi può davvero garantire il futuro dell’azienda e capire che per un figlio puoi comprare le competenze permettendogli, per esempio, di fare un’università prestigiosa, ma non le motivazioni e le inclinazioni».
Qualche volta, poi, i “destinati alla successione” vogliono bruciare le tappe. «Serve umiltà da parte di tutti: dei giovani nel conquistare autorevolezza e dei loro genitori quando si trovano a decidere che magari è meglio affidarsi a un manager esterno» continua l’esperto. «Elemento cruciale è il riuscire a comunicare. Oggi ai vertici delle aziende ci sono 3 generazioni: i nipoti 20enni, i padri 50enni e i nonni 70enni parlano lingue diverse in quanto portatori di visioni e valori differenti. È utile creare tre o quattro volte l’anno tavoli di condivisione dove con un consulente che fa da “mediatore” si riesce a esprimersi senza paura di dire sciocchezze e a valutare senza preconcetti le proposte degli altri».

