Cosa succede se la casa che ha custodito come uno scrigno i nostri progetti di vita va in pezzi, quando un matrimonio naufraga o i figli grandi lasciano il nido? Tocca trovare nuove case in cui ricostruirsi o, alle strette, divertirsi a sognarle. Un percorso che nella Autobiografia in movimento, articolata da Deborah Levy in un’avvincente trilogia, equivale a riscriversi. Con Bene Immobile (NN Editore), terzo capitolo della saga che ha appassionato legioni di lettrici di generazioni diverse, la scrittrice di origine sudafricana, londinese d’elezione, aggiunge il tassello che completa il grande affresco abbozzato coi primi due libri: Cose che non voglio sapere e Il costo della vita. E suggerisce che forse una trilogia non basta più.
Bene Immobile, il nuovo libro di Deborah Levy
In una spregiudicata gincana tra passato e presente, memoir e critica sociale, leggerezza e denuncia, in continuo dialogo con le scrittrici che l’hanno influenzata, la voce della sua protagonista, «un io narrante che mi assomiglia ma non del tutto», ci scorta per mano in una nuova fase della sua vita. Al centro dell’ultimo romanzo, la reinvenzione del concetto di casa, a lungo considerata un confinamento del femminile, come contenitore di infiniti progetti di autodeterminazione. Se Il costo della vita si soffermava sulla decisione della protagonista di lasciare la casa di famiglia e ricominciare, a 50 anni, in un condominio di periferia insieme alle figlie adolescenti e sull’energia creativa scaturita da questa deriva drastica, Bene immobile accompagna la decade dei 60 col nido di nuovo vuoto e le figlie all’università. Quando è tempo di fantasticare, sulla scorta di una serie di viaggi tra Parigi, Berlino, l’India e la Grecia, intorno a nuove proprietà immobiliari, reali e immaginarie. Dimore che, nell’eco della “stanza tutta per sé” di Virginia Woolf, più che un bisogno di sicurezza, esprimono il desiderio di tracciare e occupare un territorio artistico, di riconnettersi con le proprie ambizioni, bisogni, desideri.
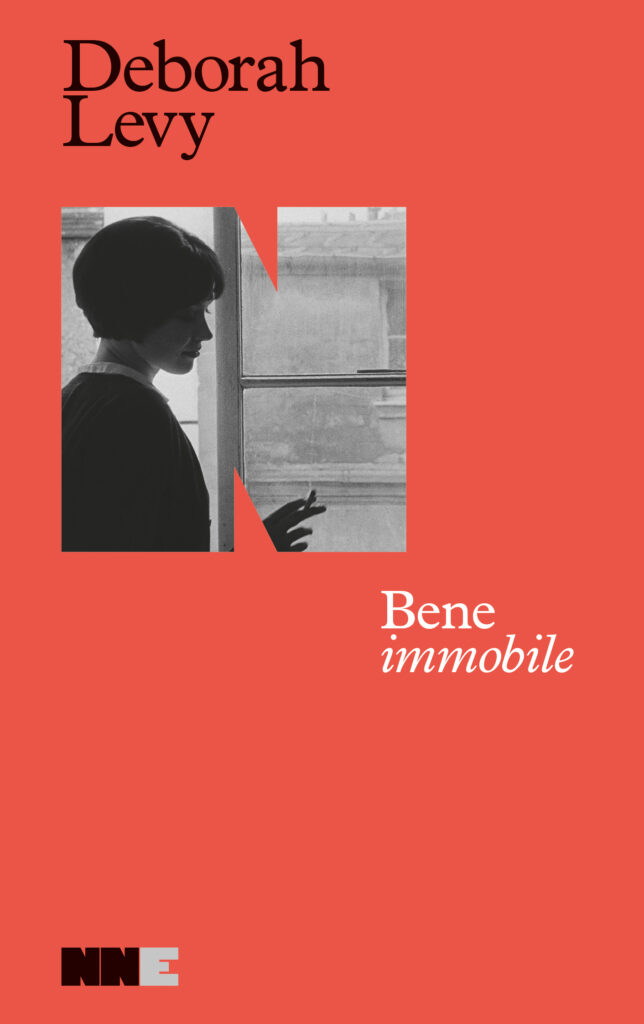
Intervista a Deborah Levy
Progetti immobiliari come metafore di libertà?
«Nei primi due libri la protagonista abitava le sue case con le figlie. Quando le ragazze crescono e se ne vanno, ritrovandosi sola, si chiede: e adesso? Che casa mi cerco? Comincia a fantasticare su dimore vere o immaginate, principesche, fuori portata, molto diverse da quelle costruite da madre: un portfolio di proprietà immobiliari che libera idee potenti, un viaggio altrove. Si chiede: cosa voglio nella mia vita? Con chi potrei condividere questa casa immaginaria? A volte, peraltro, costruire una casa nuova vuol dire demolire quelle vecchie».
Per viaggiare leggere nell’autobiografia in movimento?
«Per alzare la testa, allargare le prospettive e chiederci: vogliamo continuare a essere inquiline? Affittuarie di un terreno di proprietà del patriarcato?».
La trilogia ci insegna a immaginare personaggi femminili liberi.
«Sembra che in ogni fase dell’esistenza siamo costrette a conformarci a un’idea della vita delle donne scritta da qualcuno con meno fantasia di noi».
Per questo torna con insistenza sul tema dei personaggi femminili assenti?
«I tre libri cercano di esplorare questa strana condizione, che credo molte di noi condividano: sono così tante, e feroci, le immagini che la società ci proietta addosso che a volte ci ritroviamo assenti rispetto a noi stesse, non ci riconosciamo. Vale anche per i personaggi letterari, a cui dovremmo cominciare a restituire una voce e desideri autentici. Se non sei visibile a te stessa, non lo sarai per nessun altro».

La sua narratrice si dice furiosa con il patriarcato.
«E cos’altro dovremmo provare? Non è una bella sensazione vedere donne e ragazze brillanti, intelligenti e vivaci messe costantemente all’angolo, in ridicolo, in una condizione di sofferenza. Hanno così tanto da offrire al mondo. Così tanto amore da dare e ricevere. Il patriarcato è ancora saldo: più il femminismo accende le consapevolezze, più contraccolpi lui sferra. Bisogna resistere, seguire l’insegnamento di Simone de Beauvoir: facciamoci amare non per la nostra bellezza, ma perché siamo necessarie, per l’intelligenza, per il talento. Farebbe così bene al mondo. È un concetto complicato?».
Chiarissimo.
«È lo stato d’animo che anima i tre libri, uno dei temi su cui spesso si soffermano, in maniera politica, letteraria, radicata nella realtà, a tratti sovversiva. La voce narrante dribbla tra concetti semplici e snodi intellettualmente più complessi, usando qualche metafora per scioglierli».
Come quella del cavallo.
«Ah i cavalli! Nel libro cito una coppia di cavalli afgani di legno, alti oltre un metro: esistono, li ho portati a casa da un viaggio. Li guardo spesso mentre scrivo, mi suggeriscono le idee, sono le mie muse. Osservandoli, m’è venuta in mente l’espressione britannica to get on your high horse, che suppongo possa tradursi nell’andare a testa alta, non abbassare lo sguardo. Beh, credo che le donne dovrebbero farlo più spesso, senza preoccuparsi di ciò che pensa la gente. Dovrebbero starsene là in cima e godersi la vista. È una pratica che s’impara: magari il lunedì procediamo fluidamente al galoppo e il venerdì qualche scossone ci disarciona».
Stare a cavallo significa per la sua narratrice concedersi finalmente qualche piccolo piacere, come dormire tra lenzuola di seta.
«Anche se immagina dimore leggendarie, la narratrice vive in una casa modesta. Ma può sempre scegliere chi vuole intorno alla sua tavola. Con chi condividere la sua felicità. La seta è un’allegra spacconata. Coi soldi di un lavoro sottopagato lei si compra lenzuola costose e scopre che le procurano una sensazione fantastica. Ma, anche se non ne parla in modo esplicito, il suo vero sogno è scrivere libri e farli leggere a più lettrici e lettori possibili».
La voce che anima la sua scrittura passa con grazia da temi duri e scabrosi alle più squisite frivolezze. È un timbro che le appartiene o ha dovuto lavorarci su?
«Cielo! Ho trattenuto e poi versato così tante lacrime prima di riuscire a scrivere questi tre libri che doveva essere per forza una voce potente, che amalgamasse intimità, forma, un pizzico di filosofia, e – perché no? – di politica. Il mondo è poetico e politico insieme: è fatto di riflessioni altissime e bollette da pagare. Perché non far riecheggiare questo clangore di accenti, che poi è la musica della vita, nella voce della mia narratrice?».

