È il 26 dicembre 2011 quando Giorgio Panariello viene svegliato da una telefonata: il cadavere di suo fratello Franco è stato ritrovato per strada. I due si erano lasciati poche ore prima, dopo essersi fatti gli auguri di Natale. Franco «se ne era andato con la promessa, mantenuta, di aver davvero cambiato vita, una volta per tutte. E io per la prima volta sapevo di potergli credere, di potermi fidare. Invece lo avevano ritrovato buttato come un animale, anzi come un sacco di rifiuti, tra le piante del lungomare di Viareggio, dove andavamo in motorino da ragazzi per guardare i passanti o i carri del Carnevale».
Inizia così Io sono mio fratello (Mondadori), il libro in cui il celebre cabarettista, comico e presentatore racconta chi era Franco, come le loro storie si siano intrecciate e per quali circostanze imponderabili a 2 persone con le stesse radici possano toccare sorti tanto diverse.

Cominciamo dal titolo: Io sono mio fratello. Cosa significa?
«Che ho avuto la fortuna di chiamarmi Giorgio anziché Franco, ma che potevo diventare come lui, essere io a vivere un destino come il suo, perché siamo cresciuti negli stessi disagi. Entrambi siamo stati abbandonati da nostra madre che, single e giovanissima (Giorgio e Franco nacquero da padri diversi, ndr), ci affidò ai nonni materni. Ma io sono del 1960, un anno prima di lui, e perciò sono stato adottato da loro, mentre Franco è arrivato quando, per mille motivi, tra cui quelli economici, non potevano permettersi di prendersi cura di un altro bambino. Così lui è finito in collegio di suore, capitando ogni tanto in visita a casa nostra».
Com’era il vostro rapporto?
«A me piaceva avere un fratello minore, anche se lo vedevo soprattutto d’estate. Mi rendeva importante essere io a insegnargli le cose. Ma il suo sentirsi indesiderato probabilmente lo ha portato nel tunnel nella droga, intorno ai 18 anni. Se la stessa infanzia fosse capitata a me, non escludo che sarei diventato come lui».
Perché ha voluto raccontare ora questa storia?
«Perché a parlarne poco dopo la morte mi sembrava di speculare su di lui. Penso a Pavarotti: 2 giorni dopo che era venuto a mancare, nei negozi c’era già la compilation dei suoi successi su cd. Ma non avevo nemmeno la lucidità sufficiente per raccontare la storia di Franco: il dolore era troppo forte e non avevo avuto il modo di riflettere su quali errori avessi commesso nel nostro rapporto. Mi è servito del tempo per elaborare il mio punto di vista su mio fratello. Poi, mentre stavo scrivendo lo spettacolo previsto per lo scorso aprile (La favola mia, rimandato a marzo 2021, ndr), ho rievocato episodi del mio passato e mi è venuto naturale includere una parte su di lui. Quando lo show è saltato, l’ho ampliata. Ero finalmente pronto a parlare di lui e desideravo rendergli giustizia per cancellare una voce che circolava: quella che fosse morto per overdose anziché per ipotermia. La verità è che, come attestato dall’autopsia, mio fratello è morto di freddo, perché è stato abbandonato per strada dalle persone con cui aveva cenato: forse aveva bevuto troppo, era stato male e loro, impauriti dall’eventualità che, con i suoi trascorsi, potesse morire, lo hanno mollato come un materasso usato in una notte gelida di dicembre».
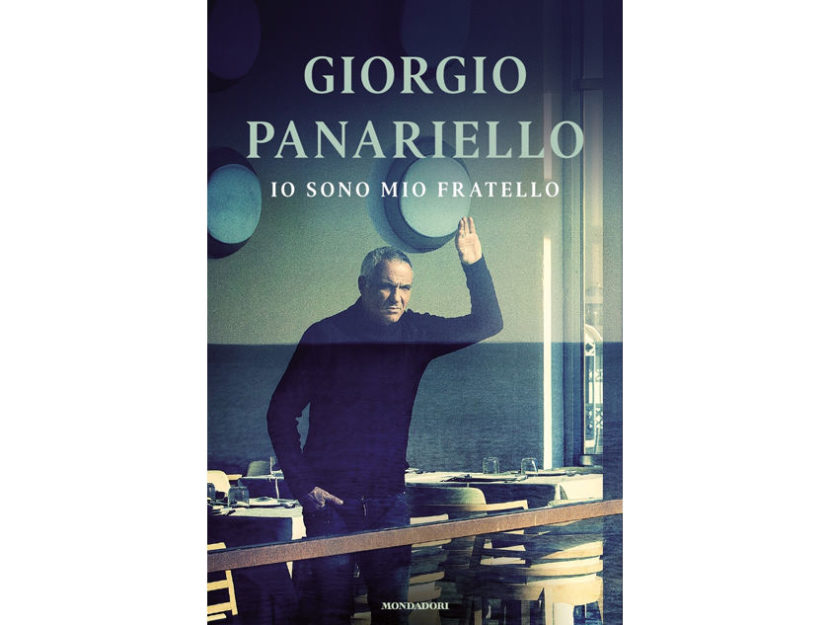
Quando si sta accanto a chi ha una dipendenza è impossibile non sbagliare. Scrivere l’ha aiutata a gestire il senso di colpa?
«Sì, contro la droga c’è poco da fare: è come essere dentro sabbie mobili, più ti muovi e più affondi. Chi si droga deve toccare il fondo per poter decidere di farsi aiutare. Grazie al cielo, quando a 37 anni Franco ha voluto chiedermi aiuto, io c’ero e potevo permettermi di sostenerlo, anche economicamente, perché le cure e le comunità costano. Oggi il senso di colpa nei suoi confronti non ce l’ho più per quanto riguarda la droga. Semmai, lo avverto per essere stato più fortunato di lui alla nascita: perché io sono cresciuto con i nonni e lui no; perché io ho vissuto in una casa riscaldata e lui, dopo il collegio, a causa dei continui litigi con mio nonno, una volta maggiorenne è andato a vivere in una baracca di lamiera… Di questo non ho vere e proprie colpe, certo, ma è difficile non pensare all’ingiustizia che è toccata a lui».
Quando è diventato famoso il senso di colpa è stato più forte
«Quando ho iniziato ad avere successo e magari guidando una bella auto per le strade di Cinquale, il mio paese, lo vedevo per strada malridotto, il dolore era devastante. Ma finché lui non ha chiesto aiuto per entrare in una comunità, non avevo un codice per capirlo, un modo giusto per avvicinarlo. Ogni tanto mi venivano a trovare amici comuni e mi dicevano di dargli una mano. Ma che voleva dire aiutarlo? Dargli i soldi con cui si sarebbe ammazzato? Prenderlo di peso e portarlo a casa, da dove sarebbe scappato dopo una settimana? Quanti confronti ci sono stati tra noi, quanti pianti. Quante promesse di cambiare vita, quanti pentimenti. E quanti lavori gli ho trovato che lui ha abbandonato… A un certo punto ho iniziato a sentirlo come una zavorra. Provavo rabbia perché volevo liberarmi di un fardello, ma al contempo mi sentivo in colpa perché non riuscivo ad amarlo così tanto come pareva necessario, e giusto, per salvarlo».
«Verso mio fratello Franco provavo rabbia perché volevo liberarmi di un fardello, ma al contempo soffrivo per l’ingiustizia che gli era toccata da bambino. Se fosse capitata a me, avrei potuto esserci io al suo posto»
Nel libro lei racconta che, quando ha avuto l’occasione di provare l’eroina, è scappato. Come se lo spiega?
«Forse è stata mia nonna a fermarmi, penso sempre che da lassù mi guardi. Ma più probabilmente è stato un barlume di amor proprio. Ero con gli amici e con mio fratello e qualcuno mi chiese se volevo fare un tiro. A meno di 30 anni ero disperato quanto lui, non sapevo che fare del mio futuro, avevo bevuto e mi ero fatto anche qualche cannetta. Così pensai: “Facciamogli vedere a ’sti deficienti che non c’è bisogno di fare tanto casino per ’sta roba”. Fosse stata polvere avrei sniffato all’istante, ma hanno tirato fuori un cristallo da scaldare su un cucchiaio… E io, davanti ai simboli di ciò che ho sempre odiato, ho provato una specie di attacco di panico e sono scappato mentre tutti ridevano e mi davano dello scemo».
Cosa le ha lasciato suo fratello di più prezioso?
«Mi ha insegnato a non giudicare le persone per ciò che hanno commesso in certe fasi della loro vita. Si dice che gli artisti vadano valutati in base alle loro opere. Ma nel caso di Franco, ecco, meglio ignorare le cose che ha fatto: ha rubato, spacciato, imbrogliato. Eppure va giudicato guardando a tutta la sua vita. E così, alla fine, mi ha lasciato di lui un’idea diversa da quella che avevamo tutti: lo ritenevano un menefreghista, un superficiale, uno che non aveva palle. Tutto smentito dal fatto che, quando ha deciso di chiudere con la droga, è stato più coerente di me. È caduto, si è rialzato, è caduto e si è rialzato ancora. Mi ha dimostrato la sua forza e il fatto che con la volontà dalla droga si può uscire. Maradona non ce l’ha fatta nel lusso e con uno stuolo di medici al suo servizio: Franco ha detto basta pur abitando in una capannetta in ferro. Quando è morto era pulito, era libero. Io non riesco neppure a smettere di fumare».
