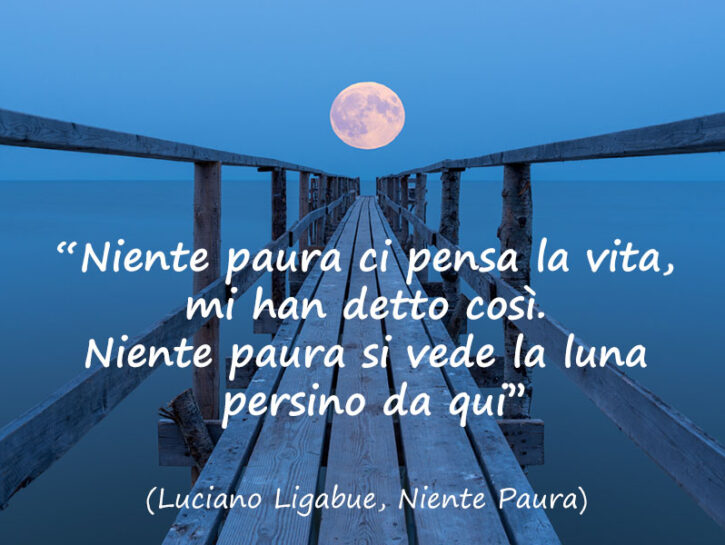Luciano Ligabue: l’autobiografia
Del resto, era già tutto evidente. Nelle canzoni, nei film, nei libri. Luciano Ligabue ha sempre raccontato di sé, di quello che gli stava succedendo nella vita. Di quello che vedeva intorno a sé. Bastava unire i puntini. Leggere fra le righe. Dare un senso ai versi dei suoi brani. Rifiutare quel luogo comune di “persona riservata”.
In Una storia (Mondadori), la sua autobiografia arrivata a 62 anni, tutto torna. C’è l’infanzia a Correggio, il rapporto col padre e la madre, Giuanin e la Rina, la balera, gli amici di una vita, i primi concerti, la fatica di farsi sentire, l’esplosione a 30 anni. E poi le donne, i matrimoni, i figli.
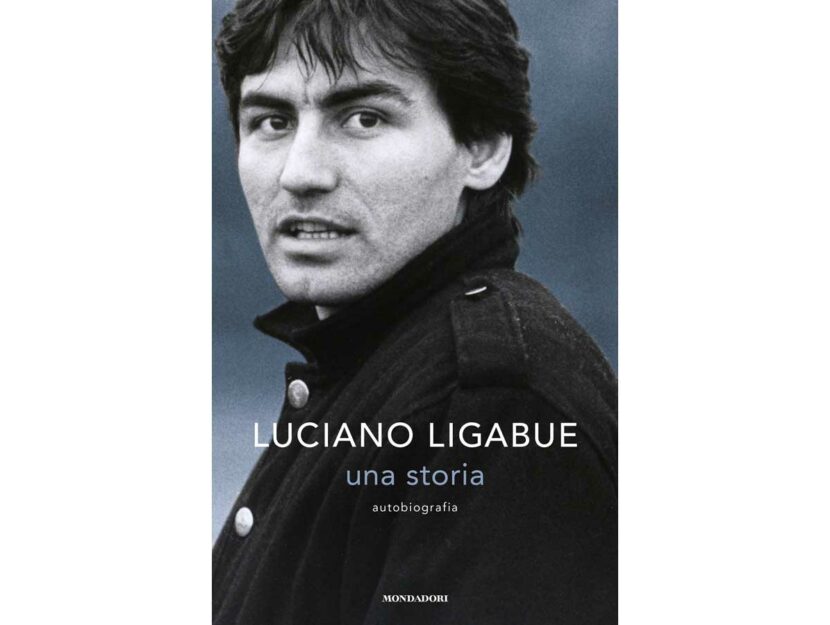
C’è il Liga privato, privatissimo, che, come dice lui, si dona ai suoi fan. “Quelli che rimangono coi sogni mezzi aperti” a cantare a squarciagola sotto il suo palco. A San Siro (nel 1997 e nel 2006) e a Monza (per il Liga Rock Park del 2016) io c’ero. Ricordo la botta di energia, la sua capacità di parlare alle persone, di farci entrare nel suo mondo. «Monza è stata una delle esibizioni più belle di sempre. Abbiamo fatto una grande serata» ride Ligabue nel suo studio a Ca’ di Pòm – la casa delle mele – a Correggio, dove prima ha vissuto e che ora ha trasformato in uffici e sede del fan club. Qui sono nate le sue canzoni e qui si sta preparando per il megaconcerto del 4 giugno al Campovolo di Reggio Emilia per i 30 anni di carriera. «Non vedo l’ora di capire anche cosa provo io. Immagino ancora molta emozione. Ma è veramente strano che io non veda i fan in faccia da 3 anni. Si è accumulata tanta roba che in qualche modo deve sfogarsi».
Intervista a Ligabue
Musicista, regista, scrittore: qual è il filo rosso che unisce tutte queste esperienze?
«Canzoni, libri e film partono sempre da un’esperienza vissuta. Da un’urgenza di dire qualcosa del mondo al mondo. Chissà da dove viene, forse solo uno psicologo può spiegarlo. Chiaro è che c’è un po’ di incoscienza, e scrivere un’autobiografia sicuramente è incosciente, ma c’è anche della presunzione. È come alzare la mano e dire: “Scusate, ho una cosa da dire”. E pensare sempre che dall’altra parte ci sia qualcuno che abbia voglia di ascoltare».
22 album, 3 film e 6 libri. Di cose da raccontare ne aveva tante.
«Per 30 anni ho maturato un mondo interiore semplicemente mio. E poi quando mi hanno “liberato”, consentendomi di pubblicare canzoni e non solo, a quel punto mi sono “vendicato”. Ho scritto effettivamente tante cose».
Lei parla di presunzione, ma in verità nelle canzoni dà del tu al fan che l’ascolta. Come scatta il coinvolgimento? «Nella mia carriera sono partito con un vaghissimo noi – pensi a Non è tempo per noi – con un contenitore che io non sapevo neanche chi potesse rappresentare, ma pensando di avere qualcosa in comune con diverse persone. Dopodiché sono passato da raccontare storie soprattutto attraverso personaggi. Raramente ho usato l’io, la prima persona, nella prima fase della mia carriera. È successo quando è nato un rapporto di fiducia da parte della gente nei miei confronti. A quel punto ho sentito che era ora di darsi in pasto ai fan. E infatti nella seconda fase della mia carriera io mi sono raccontato tantissimo. Più che nell’autobiografia però non posso fare. Ma se uno guarda a tutte le canzoni… Io direi da Miss Mondo in poi, c’è proprio un racconto personale. Dopodiché questa sensazione di fiducia fa scattare il clic del tu. È chiaro che il tu non è visualizzabile con una persona, ma è come se nella stanza in cui sto scrivendo le canzoni ci fosse una persona che rappresenta quelle che spero mi ascolteranno».
Il libro racconta il Ligabue degli inizi. Non ne ha mai parlato così.
«Forse l’ho abbozzato in qualche intervista quando mi domandavano dei 30 anni precedenti il primo album, però è chiaro che non era con questa dovizia di particolari. C’è questa frase, che scrivo alla fine, in cui dico: “L’ho combinata. Ho vuotato il sacco”. Anche qua, vai a capire quali sono le molle vere che ti portano a raccontare così tanto di te. Nel momento in cui l’ho fatto da una parte ho detto: “Oh mamma”, dall’altra ho provato un senso di leggerezza. Poi è chiaro che da oggi ognuno avrà diritto a un’opinione sulla mia vita. E siccome non sarà più su una canzone o su un film, le critiche rischiano di fare più male».
Ne esce comunque non come una star, ma come un uomo. Più simile al suo pubblico. Con le luci e le ombre, la vita vissuta.
«I fatti sono questi. Poi, sa, sul sentirsi star… Ci si può giocare, alla rockstar, perché è divertente, però sentirsi veramente una rockstar ti fa finire nei casini, non ti fa stare coi piedi per terra. In questo mestiere, se ti vanno bene le cose, non dipende tanto da te come vieni percepito dalla gente. Però io sono contento che nell’aletta del libro ci sia scritto: “Ligabue da più di 30 anni ci tiene compagnia”. Mi piace moltissimo pensare che il mio lavoro abbia consentito alle persone di sentirsi meno sole, di sentirsi rappresentate anche in un proprio dolore. E che attraverso le canzoni abbiano potuto avere un amico che gli passasse energia o allegria».

Di incontri, nel libro, ce ne sono tanti.
«E importanti. Il primo che mi viene in mente è Angelo Carrara (produttore discografico, ndr), anche con i problemi di comunicazione che abbiamo avuto. Ripenso a lui con affetto e gratitudine perché, se non ci fosse stato, forse non avrei nemmeno cominciato».
E poi c’è Claudio Maioli, il suo manager, e i 25 amici.
«Maioli è uno dei protagonisti del libro. E i miei amici sono fortunatamente tutti lì, ci vediamo sempre. Dopo quasi 50 anni riusciamo ancora a prenderci per il culo e a farci ridere l’un l’altro con le stesse battute».
Il primo concerto: 8 persone. Poi il successo. Il primo evento con tanto pubblico che effetto le ha fatto?
«Il primo con una band, gli OraZero, l’8 febbraio 1987, è stato epocale: lì ho capito che quella era una cosa che sapevo fare, che dovevo andare avanti. Ma il concerto che ha davvero cambiato le carte in tavola è stato a un Oktober Fest ad Alessandria, ottobre 1990: è stata un’esperienza fortissima vedere che metà delle persone sapeva tutte le mie canzoni e me le cantava. Era come una festa in cui l’invitato ero io. Una cosa che ancora oggi vivo così».
C’è energia ma anche malinconia nelle sue canzoni.
«Sì, ho una predisposizione alla malinconia ma ho anche una predisposizione all’euforia. E credo si sentano molto. Penso di avere sempre mantenuto una scrittura abitata dai sentimenti».
L’amore e le donne. Nel libro parla della sua prima moglie e della canzone che le ha dedicato. E poi della seconda e del drammatico aborto spontaneo.
«Di quell’episodio avevo parlato in terza persona in uno dei racconti di Scusate il disordine. Non me la sentivo di renderlo esplicito. Fa parte della vita vissuta, un’esperienza tosta che ha avuto come conseguenza ombre e luci. Quando si passa attraverso un dolore grande se ne può uscire rafforzati, è vero, e magari anche più consapevoli di quello che si ha. È stato anche così».
Il numero 7 che ricorre sempre nella sua carriera, che significato ha?
«Avrà notato che nella mia autobiografia mi è piaciuto giocare anche con un po’ di esoterismo: la pelle di biscia, i numeri dell’Ermelina, la zingara, i 3 fili colorati. Sono cose che ho messe lì, a ognuno la propria lettura. Il 7, come racconto nel libro, ha una sua storia: è successo che un giorno viene un mio collaboratore che filtrava le lettere che mi mandavano – era ancora il periodo in cui si scrivevano le lettere a mano – e mi dice: “Queste due le devi leggere”. Erano di due numerologhe che mi spiegavano: “Tu sei un 7 che cammina perché: il mio nome è fatto di 7 lettere, il cognome idem, le mie iniziali sarebbero due 7 rovesciati, sono nato il 13-3, 1960, san Luciano è il 7 di gennaio…”. Insomma, ho pensato, è sempre stato il mio numero preferito. Ed è stato anche divertente vedere come il 7 avesse avuto un peso specifico anche in precedenza: il mio primo concerto l’ho fatto nel 1987, il primo stadio nel 1997, la mia canzone di maggior successo, che è Certe notti, l’avevo messa casualmente al numero 7 di Buon compleanno Elvis. Da allora, quando io e Maio vogliamo trovare un pretesto per fare concerti o fare uscire un album diciamo “ok 7 canzoni”, oppure come L7 che è stato un tour in cui abbiamo fatto 7 concerti all’ex palaeur di Roma, 7 concerti al Forum di Milano e 7 concerti negli stadi».
Non ha un portafortuna quando sale sul palco?
«No non ce l’ho. Le uniche cose che mi ritrovo a fare scaramanticamente è quando guardo le partite dell’Inter. Allora, non so perché, ma prendo sul divano la stessa posizione che ho avuto quando in genere vince. Metto sul tavolino le cose più o meno nello stesso ordine. L’Inter mi ha educato, con tutte le sofferenze che abbiamo patito, a una scaramanzia assurda» (ride).
Nel 1999 aveva deciso di ritirarsi. Perché?
«All’apice della carriera ho avuto un periodo di crisi. Venivo da Buon compleanno Elvis, da Su e giù da un palco, successi al di sopra di qualsiasi aspettativa. La gente parlava non con Luciano Ligabue ma con l’idea che si era fatta di me. Mi sono ritrovato sempre più isolato. E sempre di più mi sono dovuto rifugiare nei miei covi, con le persone che mi conoscevano davvero. E poi dovevo difendere una privacy che mia moglie (la prima, ndr) assolutamente voleva. Mi sembrava tutto eccessivo. Anche le mie sensazioni. Avevo deciso di ritirarmi, però una sera ho preso in mano la chitarra e ho scritto Sulla mia strada pensando: “Se adesso racconto le mie difficoltà di questo momento magari le esorcizzo”. Miss Mondo è uscito così. Il disagio l’ho raccontato attraverso Si viene e si va, Una vita da mediano. Mi hanno permesso di fare un po’ di leggerezza dentro di me e così sono ripartito. E devo dire: meno male! Se avessi smesso a 40 anni, avrei rinunciato agli oltre 20 anni di concerti che sono seguiti (finora, nella sua carriera, se ne contano 800, ndr). Ce l’avrei avuta con me stesso per tutta la vita».
L’operazione alle corde vocali nel 2017 scrive che l’ha spaventata perché pensava di non poter più cantare…
«Prima di tutto c’è stato il trauma: sul palco pensi a un La e ti esce un Sol. O un sol diesis se va bene, e quindi stoni per tutto un concerto. Sai che non ci arrivi però sai che è tuo dovere non scendere dal palco. Io non l’ho mai fatto. E quindi quel 14 marzo 2017 al Forum di Assago è stata la mia peggiore performance di sempre. La ricordo come una cosa di cui ho provato vergogna. È stato un concerto vero, al di fuori di ogni dubbio. Poi però dopo che ho fatto l’operazione ho sentito molto affetto, moltissime testimonianze da molti colleghi che mi rassicuravano e mi hanno fatto molto piacere. La mia voce è il centro di tutto: non c’era solo l’aspetto meccanico, lo sapevo che andavo sotto mani esperte, era l’aspetto psicologico, quello di far lavorare qualcosa che ho sempre fatto lavorare naturalmente e ora aveva avuto un tagliando. I primi concerti dopo l’operazione sono stato “schiscio”: avevo la preoccupazione e il senso di colpa di mandare a casa la gente non con quello che avrebbero meritato. Se sto bene, se mi lascio andare credo di mandare a casa la gente con la sensazione che meritano, di un biglietto ben pagato. Un segnale di affetto in qualche modo ricambiato fino in fondo. Se non ci riesco, il mio senso di colpa a quel punto diventa intollerabile».
All’interno del libro si domanda: “Cos’è che fa diventare le canzoni la colonna sonora dei momenti importanti nella vita delle persone?”. Ha trovato la risposta? «No. Però continuo a pensare che sono le canzoni che fanno come vogliono loro. Succede che canzoni che hanno l’aria di diventare un grande successo non lo diventano e altre che invece tu butti un po’ lì arrivano con una potenza che non ti aspettavi. E questo è il bello e il terrificante dello scrivere canzoni. È un mistero insondabile. Sono parole che si devono abbinare a una melodia e che passano attraverso la vibrazione di un cantante. Io ho anche la fortuna che la mia voce, che è quella di uno che ha avuto un’operazione sbagliata alle tonsille a 5 anni, ha però la qualità di essere riconoscibile e di saper riuscire a trasmettere quello che mi va di dire. Anche lì non posso che essere grato perché non è un merito. È che è andata così».